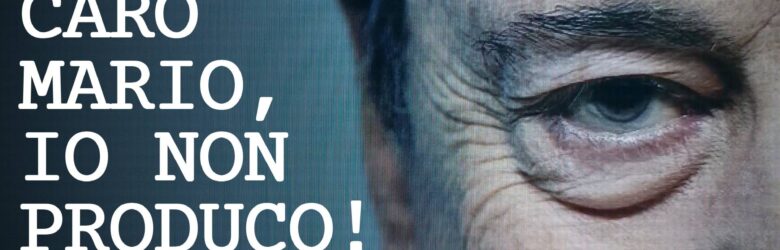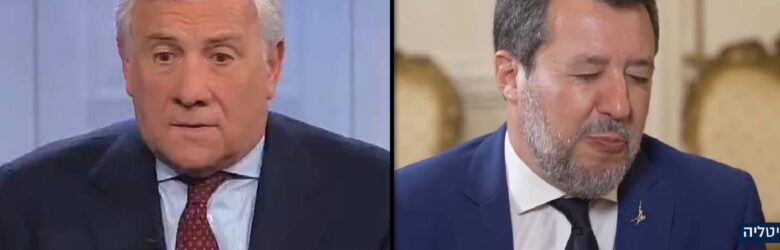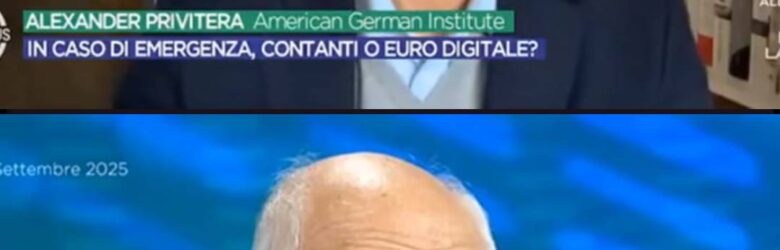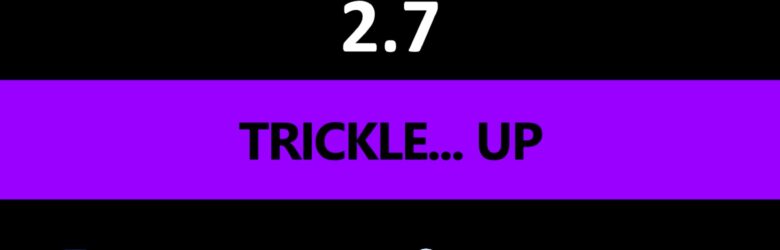Giù la maschera! È solo neoliberismo!
Finalmente Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha pronunciato la parola magica.
Hanno provato a chiamarla “semplificazione”, ma la neolingua ha i suoi limiti, e soprattutto il popolo non è così attento da rappresentare un pericolo anche quando si usano le parole giuste, senza edulcoranti; perciò, alla fine Ursula ha usato la parola magica: “deregulation”.
Durante il suo discorso al summit della Concorrenza di Copenhagen tenutosi il 1° ottobre,
la presidente della Commissione europea ha annunciato u cambio di rotta epocale. Ricordate il green deal, le riforme per l’ambiente… Era uno scherzo.
Serve semplificazione. Anzi: deregulation, appunto.
In pratica il solito polpettone neoliberista la cui ricetta è rimasta identica da quando fu applicata su vasta scala negli anni Settanta del Novecento (ricordiamo Reagan negli USA e Thatcher in UK): la fede cieca nell’idea che la regolamentazione statale sia un freno alla crescita e all’efficienza, che gli stati e persino la società dovessero comportarsi come delle aziende.
Una ennesima forma di “Taylorismo” che non vede l’ora di far genuflettere gli interessi pubblici alle manie di grandezza dei lobbisti in virtù del sacro profitto, pardon, produttività, crescita, PIL.
E quindi meno “stato”, meno regole, meno tasse, meno controlli.
Insomma, parafrasando Ursula, per rendere le cose più facili alle aziende dobbiamo tornare indietro per andare avanti, rispondendo alle richieste del mondo produttivo di rendere l’agenda di sostenibilità più praticabile.
Questo significa che l’ambiente e l’ecologia dovranno sottostare alle necessità produttive delle grandi aziende; significa che saranno messe in discussione le regole sulla sicurezza alimentare allentando il controllo sui pesticidi utilizzati in agricoltura; significa che molte più sostanze pericolose saranno permesse nei prodotti europei; significa diminuire i controlli e le certificazioni richieste alle aziende che operano sul mercato; significa diminuire la responsabilità delle aziende rispetto a quello che immettono sul mercato e ai possibili danni alle persone o all’ambiente.
Addirittura, dopo tutta la baraonda fatta per le auto elettriche, si potrebbe mettere in discussione lo stop al motore termico.
Ovviamente il mercato non si fa attendere e i colossi aziendali hanno promesso investimenti clamorosi… se si procede con la deregulation. Una forma palese e alla luce del sole di lobbismo.
Che cosa significa? In parole povere: fanculo l’ambiente, la decarbonizzazione, la sostenibilità e il green! Abbiamo scherzato. Sono le aziende a comandare e si fa quello che serve. Quello che serve a loro, ovviamente! In fondo, è solo neoliberismo! Lo è sempre stato.